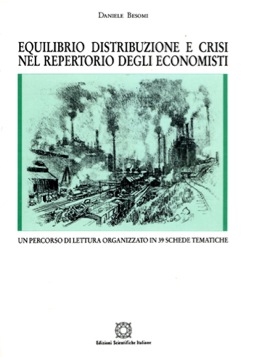Equilibrio, distribuzione e crisi
Si riproducono qui 40 articoli (10 dei quali scritti da
Giorgio Rampa) come apparsi originariamente sul settimanale
Azione tra il 30 gennaio 1992 e il 3 novembre 1994, prima di essere stati raccolti in volume per le edizioni ESI dal titolo
Equilibrio, distribuzione, e crisi. nel repertorio degli economisti. Un percorso di lettura organizzato in 39 schede tematiche (Napoli, 1995). I files sono in formato
Djvu, e per essere visualizzati richiedono l’installazione di un
plug-in (
avvertenza per mac OS)
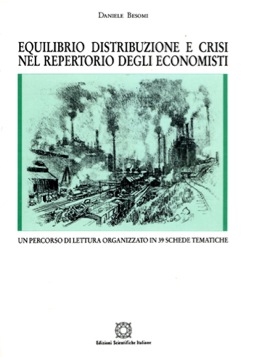
A partire da questo numero, proporremo una serie di articoli che tratteranno di alcuni tra i problemi più vivacemente dibattuti nel corso della storia del pensiero economico. La scelta di una prospettiva storica ha lo scopo di permettere al lettore di risalire ai contesti teorici cui si riferiscono le posizioni attuali degli economisti, e di valutarne l'implicita valenza politica .
L'economia politica diventa una scienza autonoma quando i rapporti capitalistici di produzione, caratterizzati dall'incontro sul mercato del lavoro di uomini liberi, soppiantano i rapporti servili che caratterizzano la produzione dell'epoca feudale.
Il Tableau économique dei fisiocratici costituisce il primo tentativo di rappresentare l'intero processo produttivo con un semplice schema numerico. Questo schema mostra come devono avvenire le transazioni tra classi economiche e quali trasformazioni deve subire il capitale affinché la produzione possa avvenire nuovamente l'anno successivo. Lo schema di Quesnay si rivelerà rilevante anche per teorizzazioni più recenti riguardanti il funzionamento del sistema economico.
Nell'opera di Adam Smith troviamo la prima trattazione sistematica dell'economia politica. Essa costituì la principale fonte di ispirazione per gli economisti fino alla metà dell'Ottocento. Ciò non esaurisce comunque la sua rilevanza per la storia del pensiero: dalle sue conclusioni contraddittorie si sono infatti sviluppati i principali filoni antagonisti dell'analisi economica, le cui divergenze permeano il dibattito contemporaneo
Anziché occuparsi della determinazione delle cause della ricchezza delle nazioni, David Ricardo si è interessato delle leggi che ne regolano la distribuzione tra proprietari terrieri, capitalisti e lavoratori. L’imbarazzante risultato cui giunse è che lo sviluppo economico comporta inevitabili conflitti tra le classi sociali.
Con Sismondi e Malthus l'economia politica riconosce per la prima volta che il funzionamento dell'economia capitalistica non è privo di difficoltà e di complicazioni.
In questo primo articolo sul pensiero economico di Marx si cercherà di andare alla radice della sua nozione di sfruttamento dei lavoratori, concezione nata da un esame critico dell’economia politica degli economisti classici.
Per Marx , le crisi economiche risultano dalla coesistenza di due esigenze contraddittorie per la produzione capitalistica: la realizzazione di un profitto e la soddisfazione dei bisogni.
Il dibattito che si aprì alla fine del secolo sul crollo o sull'espansione del capitalismo tra i teorici marxisti ripropose all'attenzione degli economisti gli schemi di riproduzione elaborati da Marx ispirandosi al Tableau économique di Quesnay.
L'analisi input -output proposta da Leontief permette di studiare l'interdipendenza tra settori produttivi, e di misurare le ripercussioni sull'intera economia di variazioni che occorrono in uno specifico ramo economico.
Alla fine dell'ottocento si definiscono i caratteri della teoria economica che ancora oggi costituisce la principale materia prima dei libri di testo. Un esame dei punti di distacco dalla tradizione classica.
Con l'economista William Stanley Jevons l'economia politica inaugura la tendenza ad unificare la trattazione del consumo e del valore, della produzione e della distribuzione del reddito, impostando l'analisi sulle variazioni di utilità anziché sui costi di produzione.
Essendo considerato, assieme a Jevons e Menger , padre fondatore della teoria economica oggi dominante, Léon Walras è tuttavia ricordato in modo particolare per aver dato avvio al programma di ricondurre l'economia nell'alveo delle scienze esatte e formalizzate
Pareto diede il via ad una nuova concezione dell'utilità individuale, qualificandosi come economista «moderno» agli occhi della teoria oggi dominante. Benché il suo nome sia in bella evidenza in tutti gli odierni manuali di economia, pochi menzionano la sua disillusione nei confronti della «scienza economica» in quanto scienza del sociale.
Cari Menger è uno degli autori la cui opera ha impresso una svolta al pensiero economico, contribuendo ad impostarlo nella direzione ancora oggi dominante ma al contempo prestando attenzione alle interazioni tra individuo ed istituzionI.
Secondo Schumpeter la produzione capitalistica è caratterizzata da continue trasformazioni e da interdipendenze tra individui ed istituzioni delle quali l'economia ortodossa non può rendere conto.
Con Marshall l 'economia politica diventa definitivamente materia di studio a se stante. La sua analisi della domanda e dell'offerta é quella insegnata ancora oggi nei corsi elementari di economia.
La teoria neoclassica della distribuzione del reddito descrive un mondo in armonia. Questa visione tranquillizzante non è però priva di difficoltà logiche.
Scomparso 10 anni fa, Piero Sraffa ha posto nel 1925 le fondamenta per una critica alla struttura logica della teoria di Marshall, demolendone un mattone fondamentale: la costruzione della curva di offerta dell'impresa.
Fu Hayek a introdurre in Inghilterra le tesi sul capitale degli economisti austriaci, contribuendo a reimpostare il dibattito sulla teoria e la politica economica.
Introducendo in Inghilterra la dottrina dei risparmi forzati, Robertson contribuì ad impostare il dibattito teorico sulle determinanti del livello della produzione nei termini che condussero poi Keynes ad elaborare la sua Teoria Generale.
La grande crisi degli anni Trenta diede nuovo slancio alla riflessione teorica sulle cause della disoccupazione. La Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta di Keynes è il maggior contributo di quell'epoca, ed ha costituito una rivoluzione tanto per la teoria quanto per la politica economica.
Nella prima parte di questo articolo si è esaminata la parte teorico-propositiva dell'opera principale di Keynes , la
Teoria Generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta; qui si esamineranno invece la componente critica e le conseguenze della teoria sulla politica economica.
Negli stessi anni in cui Keynes lavorava alla Teoria Generale, a Stoccolma si sviluppavano degli studi sulla dinamica dei risparmi e degli investimenti che presentano interessanti convergenze con l'analisi keynesiana, ma basati su un diverso metodo di analisi.
L'economista polacco Michal Kalecki anticipò alcune tesi di Keynes a partire da una rielaborazione dell'opera di Marx .
La Società Econometrica costituì uno spazio privilegiato per quegli di economisti che, negli anni venti, erano attenti non solo alla teorizzazione ma anche alla ricerca statistica. Soprattutto all'inizio dell'attività, la ricerca si indirizzò in modo particolare sul ciclo economico, settore da cui vennero comunque anche importanti contributi teorici.
Negli stessi anni in cui gli «econometrici» lavoravano ai loro modelli dinamici, ad Oxford Roy Harrod sviluppava un'altra nozione di dinamica.
Subito dopo la pubblicazione della Teoria Generale di Keynes , gli economisti neoclassici attaccarono la pretesa di generalità della visione di Keynes cercando di ridurla ad un caso particolare dovuto a rigidità e frizioni
Durante gli anni Cinquanta di questo secolo si consolida negli Stati Uniti un filone di pensiero che, assumendo come requisito irrinunciabile della teoria economica un metodo altamente astratto e matematico, si propone di portare a compimento l'opera iniziata da Walras e Pareto: l'obiettivo é quello di dimostrare in modo ineccepibile che un'economia di concorrenza perfetta e di proprietà privata, dove ogni individuo agisce motivato eta interessi individuali, dà luogo ad un esito ordinato (equilibrio generale) e «efficiente» (ottimalità secondo Pareto). In tal modo si ritiene di aver finalmente elevato la teoria economica nell'alveo delle scienze moderne e «esatte».
A partire dagli anni Cinquanta, si sviluppa un filone della teoria neoclassica che studia le scelte di individui razionali operanti in condizioni diverse da quella, analizzata tradizionalmente, di concorrenza perfetta. Pur consentendo di studiare in modo nuovo le situazioni di interazione economica, la teoria dei giochi assume un eccessivo grado di razionalità e di informazione da parte degli agenti, col rischio di non cogliere la natura di molti fenomeni reali
Nel 1953 un articolo di Joan Robinson nel quale veniva messo in questione l'approccio marginalista al valore e alla distribuzione diede il via ad un dibattito tra le due Cambridge (Robinson, Kaldor , Pasinetti , Sraffa , Garegnani in Inghilterra, contrapposti a Samuelson , Solow , Modigliani nel Massachusetts - e a Meade ad Oxford) sulla teoria del capitale che si protrasse fino ai primi anni Settanta.
Nel 1960 Piero Sraffa diede alle stampe un esile libricino, frutto di oltre trent'anni di riflessionì, nel quale rìprese la concezìone classìca di produzione e pose le premesse per una distruttiva critica alla teoria economica neoclassica.
Dopo l'adozione dello schema IS-LM da parte dei keynesiani si svolse, negli anni '50 e '60, un intenso dibattito sull'intervento dello Stato in economia. La discussione ruotava attorno alle ipotesi relative al funzionamento di parti specifiche dell'economia, ma all'interno di un modello di riferimento condiviso dalle due scuole.
Dopo i dibattiti degli anni Sessanta fra keynesiani e monetaristi, un nuovo filone di pensiero si afferma in macroeconomia. Sorta nell'ambiente liberista di Chicago , la Nuova Macroeconomia Classica fa riferimento ai canoni metodologici della microeconomia neoclassica e estremizza le posizioni monetariste averse all'intervento pubblico in economia.
Mentre la «scienza economica moderna» affina i suoi metodi logico-mater:natici, nella seconda metà del nostro secolo non cessano di esistere fermenti minoritari che dissentono dalla moda accademica. La scuola neo-austriaca, che si ispira all'opera della scuola di Menger oltre che a F. Hayek , ne è un esempio: essa enfatizza i fenomeni incerti e continuamente mutevoli che denotano l'operare delle economie di mercato.
La teoria economica neoclassica pone a base del proprio ragionamento l'ipotesi di razionalità che negli ultimi decenni è stata estesa a situazioni di 'scelta anche molto elaborate. Ma recentemente molti contributi delle discipline psicologiche criticano il concetto di razionalità.
Nell'ultimo decennio si assiste a una ripresa delle idee keynesiane, riproposte per mezzo di schemi che condividono con la teoria neoclassica più di un aspetto metodologico.
Eliminando l'ipotesi di linearità dai modelli degli econometrici, Richard Goodwin ha messo in luce un mondo di inaspettata ricchezza.
Istituito nel 1969, il premio Nobel per l'economia sancisce il riconoscimento accademico della raggiunta «maturità» di questa disciplina. Con poche eccezioni, i premiati appartengono infatti alla scuola che predilige l'uso dello strumento matematico o statistico. Presentiamo qui brevi profili dei premiati (anche più di uno all' anno), con eventuali riferimenti agli articoli precedentemente pubblicati.
Mentre nei precedenti articoli si mirava ad esporre i punti di disaccordo relativi all'oggetto e agli strumenti dell'analisi, ora si cercherà di mostrare il contrasto di opinioni circa lo statuto, il metodo e la storia della disciplina.